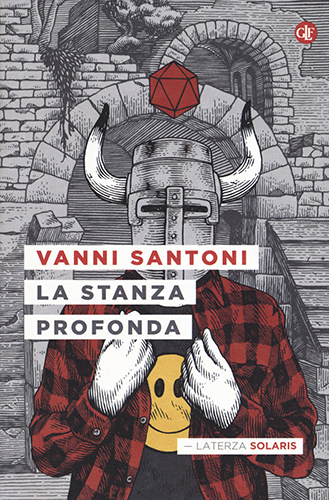La stanza profonda, Vanni Santoni
Laterza, marzo 2017, ISBN: 9788858127377
Tralasciate le polemiche del caso, che ogni anno tendono a ripetersi sempre uguali, lo Strega rimane forse il premio letterario italiano di maggior prestigio e – cosa più unica che rara per il nostro panorama così povero di lettori – popolare. Entrare nella rosa dei dodici libri presi in esame dalla giuria è ancora una consacrazione, anche per autori di lungo corso con numerose pubblicazioni alle spalle: per intenderci, uno di quei momenti in cui puoi scambiare, alla domanda “cosa fai nella vita?”, la risposta “scrivo” con “lo scrittore”.
Un forse inutile preambolo per raccontare la mia sorpresa nel trovare, fra i 12 eletti, il libro di Vanni Santoni, La stanza profonda. Non tanto per la forma e i temi affrontati, che si iscrivono a pieno titolo nella letteratura contemporanea italiana degli ultimi anni; a partire dalla commistione fra fiction e non fiction, con l’utilizzo di note prese in prestito dalla saggistica, e declinate ora all’espansione della storia per vie laterali, ora in digressioni più propriamente “accademiche” (spiegherò le virgolette fra poco); passando per il materiale autobiografico e l’utilizzo di un narratore insolito, che si rivolge a se stesso con un “tu” e che in certi passi del romanzo, con abilità funambolica, diviene un “voi”, a includere tutto il gruppo di protagonisti; per arrivare al ritrovato impegno – sociale, intellettuale, umano – che caratterizza tanta parte della narrativa di questo periodo.
La stanza profonda, infatti, si svolge sullo sfondo di un Valdarno svuotato e impoverito dalla crisi economica del 2008, come tante altre zone provinciali private di attività produttive e, quindi, di sbocchi lavorativi per i giovani, e ha come protagonisti all’inizio ragazzi, uomini e donne poi, di quella generazione per prima investita dallo smantellamento dei diritti dei lavoratori e dalla devastazione del mercato del lavoro. Precari, disoccupati, neet ante litteram (dato che solo da poco si parla di questa categoria, in realtà sempre esistita), esuli volontari in terra straniera o città lontane da quella di nascita; su tutti aleggia una certa rassegnazione e un fatalismo che la mia generazione, di poco successiva, conosce bene: andarsene per avere una possibilità dignitosa, o rimanere e venire sommersi. Chi rimane a popolare le provincie svuotate sono gli immigrati, nuovi poveri, poveri “diversi” da quelli della nostra infanzia:
Arriva un terzo bimbo, vestito, come gli altri, di un “povero” che non c’era ai tuoi tempi, ché insomma, qualcuno quelli messi peggio li aiutava, e poi la maglietta di mercato o il calzoncino di un cugino fattosi più grande toccavano a tutti e anche il povero vero staccava meno. Questi fanno pure giochi che neanche voi ai tempi, ora hanno legato il nastro di plastica a un cerchio di latta trovato chissà dove e lo fanno vorticare. Giochi da bimbi di Bruegel, da Medioevo.
Sorprendente è, però, la scelta del filtro attraverso cui raccontare queste vicende. Ciò a cui il titolo fa riferimento, e che è il perno di tutta la narrazione, è la rappresentazione appassionata di una subcultura che ancora oggi risente di un certo stigma, sociale e intellettuale, da spingere gli appartenenti all’imbarazzo e, spesso, alla giustificazione o al silenzio. Il protagonista è un master, la figura che dirige il gioco nel primo – e più celebre – fra i giochi di ruolo, Dungeons and Dragons. Un narratore, quindi, nella finzione e nella struttura del romanzo. Attraverso due linee temporali parallele, il master racconta la sua storia e la storia del suo gruppo di giocatori. Vent’anni di gioco nella stanza profonda, eretta a emblema di tutte le stanze in cui si è giocato, si gioca, si giocherà: impossibile non pensare alle serate passate in cantine, mansarde, soggiorni “che tanto i miei sono in vacanza”; i caldi tropicali e i freddi artici, le invasioni di zanzare, le sessioni interrotte da genitori esasperati dal troppo baccano: tutto sopportato, perché l’importante era giocare. Non solo per evasione, né certamente per scollamento dalla realtà, in diretta opposizione con la rappresentazione dell’opinione pubblica: oggi sono videogiochi e social sul banco degli imputati, una volta erano i giochi di ruolo. Come ricordato nel romanzo, attraverso un fatto di cronaca realmente avvenuto, si diceva rendessero antisociali, portassero al suicidio, o al satanismo. Comunque fosse, di sicuro ti rendevano uno “sfigato”.
Chi fu, la conduttrice di ViviMattina, a parlare di escapismo? Era il suo opposto. Chiudersi e produrre senso proprio perché fuori ce n’era sempre meno. La realtà si misura forse dal numero di fruitori? Non ne basta forse uno, non basta un solo osservatore per far uscire le cose dallo stato di latenza? Nel momento in cui il virtuale si sovrappone al reale, in cui tutto diventa narrazione, chi può svalutare con sicurezza quanto avveniva là sotto?
Vanni Santoni con il suo romanzo non solo rivendica l’esistenza delle tante stanze profonde d’Italia, ma eleva il gioco di ruolo a ciò che essenzialmente è: cultura. Dicevo sopra dell’utilizzo di note a piè di pagina; note spesso utilizzate per tracciare una vera e propria storia del gioco di ruolo, con tanto di fonti e citazioni bibliografiche. Per chi, come me, ha giocato, gioca ancora quando può, e ha frequentato tanti degli ambienti citati nel libro, è un’esperienza oserei dire catartica veder trattata la nostra passione con tanta serietà, con dignità, in un romanzo di tale spessore da essere preso in considerazione dalla cultura mainstream.
In fondo, tolti i dadi dalle forme strane e quell’immaginario fantasy generico e un po’ kitsch, cosa rimane, se non la condivisione di storie? Non è forse la stessa radice della passione per la letteratura?
Puoi acquistare La stanza profonda, qui.